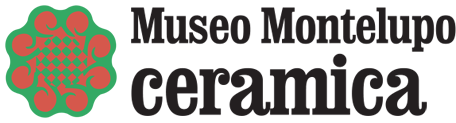#montelupoarcheologia
Il Museo Archeologico di Montelupo serba una sorpresa per gli appassionati di archeologia e di immagini misteriose antiche. Appena il Museo tornerà accessibile al pubblico, accoglierà nei suoi spazi una delle figure più enigmatiche e affascinanti del passato, la Sfinge.
La presenza della scultura etrusca in pietra vulcanica, recentemente scoperta all’ingresso di un’imponente tomba a camera ipogea della città di Vulci – potente metropoli tirrenica al confine fra Toscana e Lazio –, sarà l’occasione per conoscere e approfondire l’immaginario funerario etrusco, popolato da mostri e da belve fantastiche che l’uomo (o meglio la sua anima) doveva incontrare nel suo ultimo viaggio verso la terra dei beati.
Le eccezionali dimensioni del dromos (ingresso) della Tomba della Sfinge, lungo 28 metri, tramite il quale si accedeva al vestibolo e alle camere funerarie, testimoniano l’importanza dell’aristocratica famiglia che qui seppelliva i suoi membri. La sfinge alata risale all’età arcaica (VI secolo a.C.) ed è paragonabile ad altre ritrovate in Etruria presso le sepolture più importanti, spesso dei tumuli funerari, dove queste sculture venivano collocate come simbolo dell’aldilà e come protezione dei defunti.
L’impiego della statuaria in nenfro o in altre pietre di origine vulcanica nell’apparato decorativo delle necropoli di Vulci, a partire dal 600 a.C., non ha equivalenti in altre zone dell’Etruria. Nel territorio vulcente si è infatti sviluppata una vera e propria tradizione, che ha dato vita a una fiorente attività specialistica proseguita, senza soluzione di continuità, per quasi un secolo. A queste sculture che riproducono soprattutto sfingi, leoni, pantere, arieti, centauri e mostri marini, era demandato il compito di proiettare il monumento in un contesto ultra-terreno e di vegliare sulla pace dei morti da eventuali turbative della quiete.
L’origine della figura mitica della Sfinge va ricercata in Grecia, dove compare nel mito di Edipo. La Sfinge, testa di donna, corpo di leone, coda di serpente e ali di aquila, venne inviata da Era a Tebe per punire la città, colpevole di tollerare il rapimento del fanciullo Crisippo da parte del re Laio. Stando accovacciato sul monte Ficio, nei pressi della città, il mostro poneva a ogni viaggiatore il celebre indovinello: “Quale essere con una sola voce ha talvolta due gambe, talvolta tre ed è tanto più debole quante più ne ha?”. Chi non riusciva a risolvere l’enigma era strangolato e divorato sul posto. Solo Edipo rispose esattamente “È l’uomo”. La Sfinge, avvilita per la sconfitta, si gettò giù dal monte e i Tebani grati ed esultanti acclamarono re Edipo.

La mostra – organizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio dell‘Etruria Meridionale e il Parco Archeologico-Naturalistico di Vulci – racconta gli attimi della scoperta e la funzione della scultura posta sulla tomba, oltre alla suggestiva iconografia del mostro fantastico diffusa nell’arte etrusca.
All’esposizione si collegheranno visite didattiche incentrate sul tema della sfinge e degli esseri sovrannaturali etruschi.
Alessandro Mandolesi