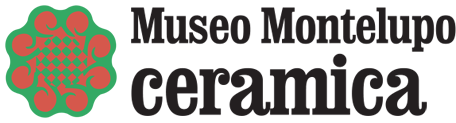#vitediceramica
Fabrizio Coli, pittore ceramista per mestiere – archeologo per passione – pittore artista per espressione. La “Mamma” del Gruppo Archeologico Montelupo, la fiamma pilota che ha dato continuità nei lunghi periodi di “stanca” alla ricerca archeologica a Montelupo…e dintorni.
Lui non sarebbe mai figurato nel Pantheon dei ceramisti italiani per le sue opere ceramiche, non faceva parte dell’aristocrazia del pennello, anzi di nessuna aristocrazia. Dentro il suo aspetto da popolano abitava un uomo di rango a cui Montelupo deve molto, anzi moltissimo. Se l’attività archeologica “volontaria” a Montelupo, iniziata nel Marzo 1973 con il Pozzo dei Lavatoi , quattro anni prima della nascita del Gruppo Archeologico, ha sempre avuto strade aperte da parte delle autorità di tutela del patrimonio storico e archeologico è stato anche perché lui era onesto, competente, perseverante e affidabile.
Onestà. Provate oggi a cercare sul web, con un motore di ricerca, “archeologo per passione”, vedrete, anche in questo 2020, un lungo elenco di denunciati per possesso illecito di beni culturali (per legge di proprietà dello Stato). Il “bonario” presidente era un severo custode dell’etica del bene pubblico che inculcava a tutti appena si affacciavano alla porta. Mai un solo oggetto, di poco pregio o di grande valore, è uscito da uno scavo o dal laboratorio del Gruppo Archeologico di Montelupo.
Competenza. Quanta polvere fece mangiare ai blasonati restauratori della Soprintendenza quando, insieme a Alberto Forconi, mise a punto un sistema di montaggio dei frammenti su contro-forma fatta al tornio e quando misero a punto la “veloce” catena di montaggio dei frammenti di enormi scavi grazie ai loro criteri “da ceramisti” di selezione dei frammenti di scavo dividendoli per materiali, tipologie ceramiche, spessori, forme e decorazioni tipiche o atipiche, o quando sostituirono le cere da restauro che “Firenze” non voleva dare! Così, anche così, ci si conquista il rispetto, sul campo.
Perseveranza e accettazione della fatica.Scavare è faticoso e, per la maggior parte del tempo, deludente, finché la punta dell’attrezzo non scopre …il tesoro. Si perché per i puri di cuore, com’era lui e come tutti i “Gammisti”, ogni frammento è un tesoro, anche i frammenti più piccoli, “le caccole”, come li chiamava Fabrizio nella sua originale e bellissima “lingua Coliana”. E com’è faticoso poi vagliare la terra di scavo, lavare i cocci, consolidare il rivestimento quando se ne va, siglarli per provenienza topografica e stratigrafica, e infine selezionarli in maniera funzionale per la stesura sui tavoli di ricomposizione nella “Sala Attacchi”.
La notte sognava giacimenti archeologici di ceramica di Montelupo, di giorno ripensava al sogno mentre era intento a pitturare sul suo tornietto in fabbrica e il sogno diventava una realtà nella sua mente. Dopo queste “rivelazioni” arrivava “al GAM” e ci diceva che bisognava fare un saggio, anzi una buca, nel tal posto “dreto la casa di… o nell’orto di…o nel campo a…”. In realtà spesso, nel sogno, prendeva coscienza di quanto aveva intravisto nelle sue continue osservazioni, urbane o campagnole che fossero. Aveva un occhio indagatore, riconosceva in un campo arato o nei materiali di scavo per la posa di una conduttura urbana indizi che pochi avrebbero colto: un piccolo frammento di laterizio, un’argilla stranamente colorata in verde rame, un piccolo”sasso scheggiato” rosso vinaccia o nero, per non parlare delle maioliche. E così, portando con sé i cuccioli e gli anziani formava tutti alla sua arte istintiva, nutrita però di studi e letture che non lo facevano sfigurare di fronte alla casta degli eruditi. Spesso i sogni corrispondevano al vero, allora battezzava gli scavi a modo suo, quasi sempre riferendosi ai proprietari o agli abitanti dei luoghi, come il famoso “Casa Cambi”, che poi venivano immortalati nelle pubblicazioni del Berti e riprese poi anche da altri autori. A questa serie dei sogni o delle visioni corrisponde il curioso episodio della “grande collezione di circa 200 Arlecchini” esposti sui muri di una nobile dimora, posata come una corona sulla testa di uno dei tanti colli che incorniciano la Conca di Firenze, con vista sulla Cupola di Messer Pippo che quest’anno accende 600 candeline.
Fausto Berti ed io, previo doveroso appuntamento, fummo ricevuti dalla padrona di casa, una nobildonna di antico lignaggio la quale mostrò sincero stupore oltre che rammarico nel dover infrangere il bel sogno: di Arlecchini nemmeno uno, nemmeno la sua ombra! Fu proprio come cantava Domenico Modugno: “Ma tutti i sogni nell’alba svaniscon perché, quando tramonta la luna li porta con sé”.
L’Italia del 1958 col suo nuovo inno nazionale di Franco Migliacci, cantato in tutto il mondo, continuò a sognare, a costruire, a produrre e a volare fino al quarto posto della graduatoria mondiale delle economie manifatturiere. Fabrizio Coli, “l’Omino Blu” di Montelupo, come in un quadro di Marc Chagall, continuò a sognare e a impegnarsi sodo, ogni giorno, nonostante tutto e tutti, e fece volare il GAM e il Museo di Montelupo in alto, tra i più prestigiosi Musei della Ceramica del Mondo. In questa impresa, ovviamente, non fu solo proprio perché sapeva condividere il suo sapere, il suo scopo e la sua volontà con gli altri, senza protagonismi e senza egoismi, mai “prima donna”. Con lui si stava bene. Questo è stato l’ingrediente segreto che ha reso “unica” e ricca di frutti la sua esistenza.
Verso la metà degli anni ’60 molti ceramisti di Montelupo e di Capraia, come pure molti operai di altri settori manifatturieri, migrarono verso le Poste e verso le Ferrovie in cerca di un lavoro sicuro e forse… migliore (?). Anche Fabrizio ci provò e ci riuscì. Entrò nelle “Regie” Ferrovie dello Stato ma gli scambi di un nebbioso scalo merci milanese non facevano per lui e, dopo un quasi mini disastro ferroviario – che noi, beninteso, per ridere ci divertivamo a ingigantire, tornò ai cocci, quelli di fabbrica per mangiare e quelli nei campi per vivere.
Era un personaggio di una poetica unica. Le sue vicende, nella loro quotidiana semplicità, in lui diventavano epiche, le gesta di un “eroe” degne di essere cantate in un “Poema” moderno, quale in fondo è un fumetto o meglio un cartone animato. Le sue avventure giovanili, i suoi gusti “boteriani”, “Che rote gliavéa, ragazzi, mi toccò pigiaccela pe’ falla entrà nella Cinquecento!”. Se avessi avuto il dono del disegno lo avrei raffigurato proprio come lo definì una delle sue bambine quando lo vide di profilo in mutande mentre si lavava il viso un po’ curvo sul lavandino, “O babbo, tu sembri un pollo!”, con le sue gambe troppo esili in confronto alla pancia “importante”. “O che si dice queste cose al Babbo!?” replicò con un tono falsamente di rimprovero. Quando ce lo raccontava, seduti al tavolo tondo o in piedi sotto la luce dei neon intorno al grande tavolo centrale della “Sala Attacchi” mentre teneva tra le mani un piatto o un boccale “in crescita”, rideva con gli occhi e con un viso così felice e compiaciuto che mi sembra di vederlo ora, mentre scrivo.
E poi le uscite week end “pe’ anda’ a fa’ pietre” o le incursioni “all’estero” come a San Genesio sulla Via Francigena, “mano rampante in campo altrui”, secondo l’araldica “Coliana”, mano armata con un metal-detector oltre che di piccone, pala e trowel. Oggi a San Miniato sono grati a lui e al GAM perché i preziosi reperti sono tutti ad arricchire l’esposizione archeologica dedicata al sito di San Genesio.
Che carisma! Ancora oggi ne sanno qualcosa i due diversi e successivi gruppi di ex giovani che lo seguivano come se fosse il Pifferaio Magico di Hamelin, a Montelupo, in Toscana, invece che in Bassa Sassonia. “Venite drento ragazzi, venite drento!” disse “quella” volta a tre ragazzi che lanciavano piccoli sassolini su quel vetro imbiancato di boiacca, curiosi di vedere cosa c’era dentro, in quel piccolo locale alle spalle di un tabernacolo ormai illeggibile sotto casa del Cucco, proprio di là al ponte del Porro. I tre ragazzi erano Paolo Ugolini, Alessio Ferrari e Paolo Piatti. Era il seme del GAM.
La musica del suo piffero magico varcò presto i confini di Montelupo e vennero “Gammisti” da Firenze, da Borgo a Buggiano, da Capraia e da Limite sull’Arno, da Scandicci, da Empoli, da Ginestra e da Lastra a Signa, da Quarrata, da Artimino, da Prato, da Greve in Chianti e da Santa Croce Sull’Arno. Il GAM divenne il Gruppo di volontari di ogni ceto sociale e di ogni mestiere e professione, il “meno locale” di tutta la Regione.
Purtroppo la luna tramontò anche su questo sogno. Il GAM ha cominciato ad allontanarsi dal prezioso e magico scrigno di ceramiche antiche qual è il centro storico di Montelupo da quando Fabrizio cessò di suonare il piffero magico della costante attenzione ad ogni scavo occasionale, dello stimolo incessante a ricercare, dell’invito agli altri, dell’accoglienza che ti fa sentire a casa in mezzo a tutti quei cocci e dentro al miracolo della “Sala attacchi”. Scagli il primo coccio quel Gammista che non ha mai trovato almeno un “attacco” in vita sua. Fabrizio ci aveva insegnato e ci spronava sempre a provare la felicità di trovarne uno, specie se dopo lunghe serate “in bianco”. E, a proposito di insegnare, se questo archeologo-per-passione non fosse stato un ceramista, non avrebbe saputo spiegare e insegnare agli “esperti” archeologi-ceramologi-storici la carta d’identità di ogni reperto ceramico, il materiale, la tecnica di foggiatura, il rivestimento, la tecnica di decorazione, il difetto di fabbricazione per il quale era stato gettato “in discarica” e così via. Con la sua spontanea semplicità ha innestato il sapere ceramico su altri saperi ritenuti – a torto – di rango superiore. Pur senza saperlo ha dato più lui alla Ceramica di Montelupo e alla sua Storia, di tanti Maestri senza allievi, troppo concentrati sul proprio pennello senza colori. Le serate “a veglia” in compagnia di due Matèussi, ovvero due “bocce” di Mateus Rosé, il vino ufficiale del GAM Coliano, che il “ragazzo” di turno andava a comprare “da Carlino”. Erano ore magiche in via dei Pozzi in quella prima metà degli anni Novanta del secolo scorso intorno al grande tavolo rotondo del GAM, opera dell’eclettico Gammista Gualtiero Gargelli, alias Gualtiero il ferroviero, Capraìno di qua d’Arno, quando Fausto Berti ci raccontava le ultime novità, fresche di giornata, delle sue ricerche storico-archivistiche. Fabrizio era “la spalla” principale che riusciva a far raccontare a Fausto come intorno al focolare, la ceramica, i ceramisti, i clienti, i litigi e le disavventure di quei tempi che affiorano, colorati, dal sottosuolo di Montelupo. Era un modo colloquiale, domestico, a volte da osteria, che ci faceva sentire dentro quel mondo e quel tempo, magari con l’aggiunta romanzata di qualche dialogo come nel processo al ceramista che era entrato a consegnar la merce in un convento di clausura a Firenze ma che non la passò liscia. Rimediò dal Granduca non mi ricordo più quanti “tratti di corda” e una multa salata. Ah! Ma che gli avrà fatto Costui alle monache!?
Come ogni Salmo finisce in Gloria, così tutte queste “veglie-prima-di-cena” finivano con la scenetta di Fabrizio che sembrava Paolo Panelli, il falegname nel “Conte Tacchia”, quando con foga accorata esortava Enrico Montesano, il figlio un po’ “svagato”, “bisogna lavorà! bisogna lavorà! bisogna lavorà!”. Così lui, tra l’irritato e il disperato diceva al Berti, affetto allora dalla stitichezza a pubblicare indotta dal rigore dello studioso, “Tu hai scritto il Vangelo della Maiolica di Montelupo, ora devi scrivere la Bibbia. Bisogna pubblicà! Bisogna pubblicà! Se no queste cose un le sa nessuno! Porca cavalla!”.
Peccato che “queste cose”, quelle dette intorno al tavolo rotondo, non siano state raccontate a tutti né sui libri, né nel museo. Altro che cocci rotti! Sarebbe stata tutta un’altra storia. Era anche questo un cruccio di Fabrizio, non essere riuscito a far innamorare della storia della ceramica i ceramisti. Ecco perché l’ho sentito come un fratello con il quale ho condiviso, appunto, un sogno.
Solo chi sogna e poi testimonia, sa indicare strade nuove e riesce a portare gli altri a percorrerle.
Stamani ti ho portato un fiore, lassù a Pulica, da dove sei partito e dove sei ritornato. Grazie Fabrizio.
Paolo Pinelli