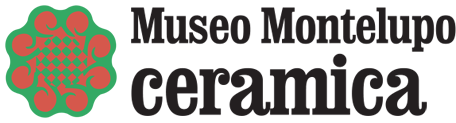#monteluponelmondo
Molte maioliche montelupine, anche fra le più raffinate, sono conservate in diverse collezioni pubbliche e private internazionali. Da Berlino a Parigi, da Città del Capo a New York, la ceramica montelupina d’interesse antiquariale ha, in qualche misura, raggiunto le stesse mete del passato, quando, grazie all’attività dei mercanti fiorentini del XV e XVI secolo, è stata una delle produzioni più esportate nel mondo allora conosciuto. Ed è innegabile che all’internazionalizzazione dell’immagine di Firenze, e delle sue grandi famiglie, abbia contribuito anche la diffusione della ceramica di Montelupo, con i suoi simboli e i suoi inconfondibili colori.
Con questa rubrica vogliamo soffermarci su un’importante serie di maioliche prodotte a Montelupo in tempi diversi, che oggi fanno bella vista nelle raccolte straniere, e che illustrano le qualità artistiche raggiunte dalle maestranze affacciate sull’Arno.
Questo grande e colorato boccale datato 1544, un “quartone” toscano, mostra lo stemma della famiglia fiorentina dei Brandi; questo è fiancheggiato da due cornucopie tipiche della decorazione “a grottesca”, in gran voga nel XVI secolo. La maiolica, conservata al Victoria and Albert Museum di Londra, è stata evidentemente commissionata per esaltare l’insegna araldica della casata. Rispetto al secolo precedente, nel pieno Cinquecento si ricerca una maggiore esuberanza decorativa con l’ausilio di serrati ornati e di elementi accessori (in questo caso la cornucopia), già dal sapore barocco, aspetto che finisce col ridurre l’equilibrio della composizione araldica.
I “quarti” e i “quartoni” sono le forme più grandi della tavola fiorentina, in quanto avevano la capacità di contenere oltre sei litri nel cosiddetto “gioco d’orcioli”, ossia di un gruppo di sei boccali che, a iniziare dal piccolo “quartuccio”, comprendeva tutte le varianti dimensionali del principale versatore da mensa. Il “gioco d’orcioli” si distingueva per un decoro organico e raffinato, particolarmente adatto alle forniture araldiche; il “quartone”, in particolare, svolgeva un ruolo dominante, ed era inteso come il pezzo più rappresentativo. Da qui l’idea per i ceramisti di forzare la sua decorazione, con l’intento di renderla il più possibile efficace a sottolineare l’insegna nobiliare.
(Red.)