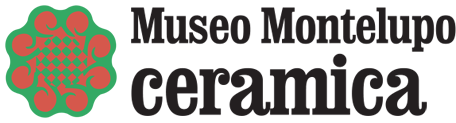#monteluponelmondo
Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle più belle maioliche montelupine conservate in collezioni pubbliche e private internazionali, opere di abili maestri che hanno lavorato per le più importanti committenze fiorentine, e non solo.
Rimaniamo in terra di Francia, con un esemplare conservato al Museo Nazionale della Ceramica di Sèvres. ma cambiamo decisamente genere rispetto alla prima maiolica „straniera“ presentata sul nostro blog. Questa elegante targa murale è datata 4 gennaio 1478, ma un occhio attento osserva dipinto 1477 nello stile fiorentino detto “dell’incarnazione”, ossia nell‘originale sistema cronologico – citato nei documenti con la formula “ab incarnatione Domini” – che pone l’inizio dell’anno al concepimento di Cristo, cioè al 25 marzo, festa dell’Annunciazione. Quello fiorentino era certamente il più diffuso, e ritardava di due mesi e ventiquattro giorni il computo moderno (dal 31 dicembre al 25 marzo).
La nostra targa si distingue per la particolare configurazione a “testa di cavallo” (così viene infatti denominata), una forma araldica tipica del tardo-quattrocento.
Nel cartiglio in alto è riportato il nome di Nicola Corsini, che evidentemente commissionò e poi collocò questa lastra in una composizione araldica allestita in facciata o all’interno di un palazzo pubblico del Contado fiorentino. Probabilmente proprio nel luogo ove esercitò le funzioni di governo, con la carica di podestà o di vicario.
La targa montelupina è fra le più antiche testimonianze di questo genere, a carattere pubblico, caratterizzata dalla presenza di angeli reggistemma, con fitti riempitivi stilizzati di gusto levantino a papavero oppiaceo. Delle figure angeliche fluttuanti colpisce la tonalità in blu coibalto che dà forte consistenza ai corpi, quasi innaturale. Qui il pittore spinge molto sulla volumetria, forse perchè il pezzo doveva essere visto da una certa distanza. Al di là delle tonalità e delle sfumature cromatiche, rimane la ricerca del tutto fiorentina di un realismo pittorico nella raffigurazione – realizzata con la “tavolozza fredda”, una monocromia intervallata dall’impiego nelle parti secondarie del verde, del bruno e del giallo che, fondendosi con l’azzurro dominante creano un effetto in visione notturna -, in uno spazio indefinito e senza tempo, che rende questi prodotti ancora di “sapore medievale”.
(Red.)